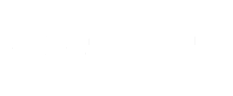Introduzione
Esattamente come l’uomo, anche gli altri animali e le piante si difendono dai pericoli. In tutti gli esseri viventi la difesa si basa su due punti fondamentali: saper distinguere sé stessi dagli altri, e riuscire ad isolare e distruggere “il nemico”. Gli animali si difendono dai pericoli in molti modi: con mezzi fisici come aculei, gusci, corazze, cercando rifugi e tane, cambiando il colore della pelle (mimetismo) grazie a particolari forme del corpo o a disegni cutanei per cui si confondono nell’ambiente in cui vivono [1].
La ricerca scientifica, grazie agli studi condotti in biologia animale, e in particolare nella zoologia evoluzionistica e nell’etologia, ha permesso nel tempo una classificazione delle manifestazioni comportamentali degli animali e dell’uomo. Nello specifico, l’ecologia comportamentale, o ecoetologia, è la branca dell’etologia che si propone di spiegare, con fondamenti ecologici ed evoluzionistici, in che modo i comportamenti garantiscono un migliore adattamento dell’animale nell’ambiente in cui vive, e dunque una maggiore probabilità di sopravvivenza.
La pulce
Le pulci sono insetti che comprendono ben 2600 tra specie e sottospecie, raggruppate in 15 famiglie ed appartenenti a 5 linee evolutive. Le loro affinità con altri insetti sono oscurate da caratteri che si sono modificati nel corso della loro evoluzione, derivati dall’adattamento parassitario.
La selezione naturale ha eliminato le ali della pulce, ma ha conservato importanti caratteristiche del meccanismo di volo. Le zampe anteriori terminano con robusti artigli progettati per afferrare l’ospite ed evitare il distacco. Il terzo paio di zampe è il più sviluppato e consente alle pulci di compiere i loro salti, in grado di coprire una distanza pari a 100 volte la lunghezza corporea. Il salto della pulce è alimentato non soltanto dalla forza muscolare, ma è coadiuvato dalla resilina presente nell’articolazione, la proteina elastica più efficiente conosciuta [2].

1. apparato boccale pungente-succhiante
2. occhio, dotato di singola lente biconvessa
3. antenna (le antenne sono raccolte in due fossette, da cui sono fatte uscire in caso di necessità)
4. zampe anteriori
5. zampe posteriori
6. setola antepigideale
7. sensilium (zona sensoriale)
La tarantola
Le tarantole sono una famiglia di ragni dalle dimensioni considerevoli. Oltre ai normali peli sul corpo alcune tarantole di origine americana hanno anche dei peli urticanti (circa 10.000 per mm²) che possono utilizzare come difesa in caso non riescano a fuggire dal pericolo. Oltre ad essere lanciati contro possibili aggressori, i peli urticanti vengono usati per marcare il territorio oppure, messi ai bordi della tana, aiutano a scoraggiare eventuali predatori, specie durante la muta. In base al tipo di nemico i peli possono dimostrarsi mortali oppure un semplice deterrente [3].
I peli urticanti della tarantola sono costituiti da setole uncinate che ricoprono la superficie dorsale e posteriore dell’addome della tarantola. Questi peli non compaiono alla nascita ma si formano ad ogni muta consecutiva, allargandosi di muta in muta e presentandosi verso l’esterno attorno ad aree di setole più scure sulla parte superiore della schiena e dell’addome dei soggetti giovani. In età avanzata la loro colorazione cambia per adattarsi al tono principale dell’addome. Nonostante questo cambiamento, i peli urticanti mantengono comunque caratteristiche uniche che li rendono visivamente distinti dalle setole addominali, come la loro tendenza a coprire solo una porzione anziché l’intero opistosoma. Esistono sette diversi tipi di peli urticanti conosciuti nelle tarantole, che variano per dimensioni e forma, in particolare per la distribuzione delle punte. Si ritiene che ogni tipo di pelo urticante prenda di mira nemici diversi.

La lucertola
Le lucertole sono un gruppo di rettili che vivono sulla terra in ambienti diversi con forme corporee diverse. Le lucertole sono altamente adattabili, alcune presentano colorazioni molteplici, che fungono da protezione o vengono sfruttate durante il corteggiamento. Lo sviluppo della colorazione della pelle delle lucertole è un fenomeno evolutivo biologico molto complesso.
I colori del corpo degli animali possono essere suddivisi in due categorie a seconda del meccanismo di formazione: colori pigmentati e colori strutturali. Il colore dei pigmenti differisce dal colore strutturale per il fatto che appare identico da ogni angolo di vista, mentre il colore strutturale è il risultato di riflessioni selettive o dell’iridescenza, solitamente dovuta a strutture pluristratificate. I colori pigmentati vengono prodotti attraverso cambiamenti nel contenuto dei componenti del pigmento e la sovrapposizione dei colori, con un funzionamento simile al principio dei tre colori primari. I colori strutturali invece si formano riflettendo la luce attraverso sottili strutture, producendo colori con diverse lunghezze d’onda della luce riflessa, basandosi sui principi dell’ottica.
Le immagini di Fig.4 mostrano i risultati dell’utilizzo dell’accessorio SEM5000-STEM per caratterizzare le cellule iridescenti nelle cellule della pelle delle lucertole, che hanno una struttura simile a un reticolo di diffrazione, in grado di riflettere e diffondere diverse lunghezze d’onda della luce. Si è scoperto che le lunghezze d’onda della luce diffusa e riflessa dalla pelle della lucertola potrebbero essere variate modificando la dimensione, la spaziatura e l’angolo di queste strutture. La caratterizzazione di queste cellule al microscopio elettronico a scansione consente di visualizzarne le caratteristiche strutturali (dimensioni, lunghezza e disposizione) che danno origine ai diversi colori, e permette così di correlare la microstruttura con la colorazione macroscopica.
Rispetto alla tradizionale microscopia elettronica a trasmissione, la modalità STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy) del SEM può ridurre significativamente il danneggiamento del campione dovuto al fascio di elettroni incidente, grazie alla tensione di accelerazione inferiore, che la rende particolarmente adatta per analisi strutturali di tessuti molli come quelli dei campioni biologici e di molti materiali polimerici.

Il gatto
Quando un gatto si sente minacciato o spaventato, viene attivata la sua risposta di lotta o di fuga, facendo alzare il pelo mentre si prepara a difendersi o a fuggire. Questo riflesso in risposta alla paura fa apparire l’animale più grande di quanto sia in realtà, nel tentativo di spaventare il nemico e farlo desistere dalla lotta. Lo stesso riflesso si ha in situazioni di freddo ambientale, poiché determina l’intrappolarsi di uno strato d’aria tra il pelo e la cute, che si scalda a contatto con la cute stessa, fungendo così da isolante termico, riducendo la dispersione del calore corporeo.
Ma non tutti i peli sono uguali, e il microscopio elettronico a scansione, grazie all’elevata risoluzione e alla tridimensionalità dell’immagine acquisita da diverse angolazioni, permette di ottenere una rappresentazione più chiara e più precisa della microstruttura dei peli.

Come si può vedere dalle immagini acquisite al SEM su un pelo di un gatto di razza British Shortair (diametro di circa 58 μm), la superficie presenta un’evidente struttura ondulata. La distanza assiale tra ciascuna ondulazione è di circa 5 μm. Questo valore incide sulla flessibilità dei peli: maggiore è il rapporto tra il diametro del pelo e la distanza tra le squame, migliori saranno la morbidezza del pelo e la sua resistenza. Lo spazio tra le squame sollevate e il fusto del pelo determina inoltre la quantità di aria che il pelo può immagazzinare. Pertanto, una diversa morfologia delle unità superficiali determina anche una differenza nelle prestazioni di isolamento termico del pelo del gatto.
Anche la sezione trasversale del pelo può fornire molte informazioni. In generale, dall’esterno verso l’interno, i capelli sono composti da tre strati concentrici: squame, corteccia e midollo (Fig.6). Lo strato di squame più esterno è composto da cellule piatte che si sovrappongono e ricoprono la superficie del pelo con una forma simile a quella delle squame di pesce. Sono disposte dalla radice del pelo alla punta e avvolgono la corteccia interna. Sebbene questo strato sia molto sottile, funge da protezione per il pelo. Lo strato di corteccia subito sotto è composto principalmente da cheratina morbida. La struttura a catena della cheratina rende i peli elastici e difficili da spezzare. Il midollo pilifero si trova al centro del pelo ed è composto da un agglomerato di cellule senza nucleo. All’interno la struttura del pelo è cava: l’aria contenuta ha un effetto di isolamento termico.

Dalle immagini SEM ottenute sulla struttura in sezione trasversale si possono distinguere chiaramente i tre strati che compongono il pelo: squame esterne, corteccia media e midollo centrale. Nelle immagini è ben visibile la struttura porosa in grado di trattenere l’aria.
Conclusioni
In sintesi, osservando il pelo degli animali al microscopio elettronico a scansione, è possibile ottenere molte informazioni utili non solo ai fini della tassonomia ma anche per la comprensione dello stato di salute, delle abitudini di vita e dei meccanismi di difesa dell’animale.
Inoltre, lo studio della microstruttura del pelo è anche un importante punto di partenza per la ricerca e lo sviluppo di materiali innovativi con buon isolamento termico, funzioni idrofobiche e flessibili, nell’ambito della bionica, ovvero l’applicazione di metodi e sistemi biologici presenti in natura nello studio e nel design di sistemi ingegneristici e della moderna tecnologia.
Bibliografia
[1] Meccanismi di Difesa, di Alessandra Magistrelli, Geni Valle, Treccani (2005)
[2] Pulci, Piero Sagnibene, NATURALMENTE Scienza
[3] The urticating hairs of theraphosid spiders, Cooke, J.A.L., Roth, V.D., Miller, F.H. (1972). American Museum novitates 2498.
[4] Application of Scanning Electron Microscope (SEM) in the study of animal hair microstructure, CIQTEK (2024)